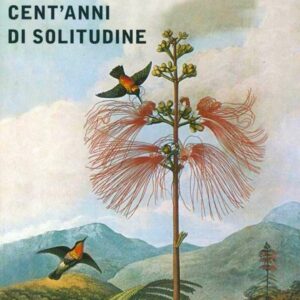
L’espressione “realismo magico” venne coniata nel 1925 dal critico d’arte tedesco Franz Roh. In un saggio intitolato appunto Post-espressionismo. Realismo magico, Roh la usò per descrivere il movimento pittorico della “Neue Sachlichkeit”, la “Nuova oggettività”, che all’epoca si stava diffondendo in Germania in alternativa alle correnti del romanticismo e dell’espressionismo. La sua intenzione era quella di sottolineare il carattere magico, fantastico e quasi straniante di molti oggetti rappresentati nei dipinti dell’epoca e appartenenti al mondo reale. Due anni dopo il saggio di Roh fu tradotto in America Latina, dove il realismo magico diventò sempre più popolare. Anche lo scrittore franco-russo-cubano Alejo Carpentier fu influenzato da quello che in seguito lui stesso definì “realismo meraviglioso”, con una piccola variazione che a suo parere meglio si adattava al mondo sudamericano nel suo complesso.
Nel 1955 il critico letterario Angel Flores utilizzò l’espressione “magical realism” in un saggio in lingua inglese, affermando che essa combinava elementi di realismo magico e realismo meraviglioso e citando lo scrittore argentino Jorge Luis Borges come primo rappresentante della nuova corrente, grazie alla raccolta di racconti Storia universale dell’infamia (pubblicata nel 1935). Tuttavia, molti autori precedenti avevano descritto situazioni quotidiane ricorrendo a elementi fantastici, ben prima che il realismo magico fosse riconosciuto come un genere letterario. Basti pensare a Franz Kafka e alle sue Metamorfosi, pubblicate nel 1915, ben dieci anni prima che Roh ne coniasse la definizione.
Ma quali sono esattamente le caratteristiche ricorrenti di questo genere narrativo?
. Ambientazione realistica: tutti i racconti del genere si svolgono in un mondo che al lettore risulta conosciuto e familiare.
. Elementi magici: dagli oggetti parlanti ai personaggi defunti alla telepatia, ogni romanzo appartenente a questa categoria contiene elementi fantastici che non appartengono al mondo reale. Eppure, all’interno della narrazione essi vengono presentati come “normali”.
. Informazioni limitate: gli autori evitano deliberatamente di spiegare gli aspetti magici della storia, in modo da “normalizzarli” il più possibile e rinforzare la convinzione che siano parte integrante della vita quotidiana.
. Critica: spesso gli autori utilizzano il realismo magico per criticare implicitamente la società contemporanea, in particolare le élite e la classe politica. Non a caso questo genere si sviluppò in un’America Latina oppressa e sfruttata dai Paesi occidentali, permettendo ai suoi rappresentanti di prendere le distanze dall’imperialismo degli Stati Uniti.
. Trama: i romanzi del realismo magico non seguono un arco narrativo classico, con un inizio chiaro, uno sviluppo e una fine. Questo genera un’esperienza di lettura più intensa, nella quale il lettore non sa quando il racconto procederà o quando avranno luogo dei conflitti.
Analizziamo adesso alcuni esempi di romanzi che si possono ascrivere al genere del realismo magico:
- Cent’anni di solitudine di Gabriel Garcia Marquez (1967) è la storia di più generazioni della stessa famiglia e del suo patriarca, che sogna di una città fatta di specchi chiamata Macondo, costruita sulla base delle sue percezioni.
- I figli della mezzanotte di Salman Rushdie (1981) ha per protagonista un ragazzo dotato di poteri telepatici, nato alla mezzanotte del giorno in cui l’India conquistò l’indipendenza.
- La casa degli spiriti di Isabel Allende (1982) narra la storia di una famiglia e di una donna dotata di poteri paranormali, oltre che della capacità di connettersi con il mondo degli spiriti.
- Amatissima di Toni Morrison (1987) è la storia di un ex schiavo perseguitato da un fantasma aggressivo.
- Come l’acqua per il cioccolato di Laura Esquivel (1989) racconta di una donna che riversa le proprie emozioni nell’arte della cucina, provocando effetti indesiderati in chiunque assaggi i suoi piatti.
- L’uccello che girava le viti del mondo di Haruki Murakami (1994) ha per protagonista un uomo in cerca prima del suo gatto e poi della moglie scomparsa, in un mondo parallelo situato al di sotto delle strade di Tokyo.
- L’oceano alla fine del sentiero di Neil Gaiman (2013): un uomo riflette sul passato in occasione del suo ritorno a casa per un funerale.
- Cecità di José Saramago (1995) è un romanzo in cui la popolazione viene colpita da un’epidemia di cecità, che in breve conduce la società al collasso.
- I libri di Jakub di Olga Tokarczuk (2014) narra la vicenda di Jacob Frank, mistico e fondatore di una setta nel XVIII secolo, dotato di un carisma soprannaturale.
- Le sei reincarnazioni di Ximen Nao (2006) è narrato dalla prospettiva degli animali, e utilizza il concetto buddista di “ruota della vita” per illuminare mezzo secolo di cambiamenti epocali nella società cinese.
Riguardo a Cent’anni di solitudine, Garcia Marquez affermò di essere sorpreso e divertito dal fatto che “i più grandi elogi del mio lavoro riguardano l’immaginazione, quando in verità nelle mie opere non c’è una sola riga che non abbia una solida base di realtà”. Macondo è una città solitaria che riflette il mondo circostante, nella quale vivono da sempre le diverse generazioni della famiglia Buendía. Nel corso dei secoli, vengono colpite da una serie di sfortune ricorrenti, che comprendono tappeti magici, spiriti persecutori e bambini con la coda da maiale. Il microcosmo di Macondo riflette la realtà di un intero continente, il Sudamerica, la sua povertà ma anche il surrealismo che permea la vita quotidiana e che, come ebbe a dire lo stesso garcia Marquez, “corre per le sue strade e costituisce la realtà più profonda dell’America Latina”.
